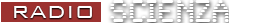QUANDO I NOMI PRENDONO IL POSTO DELLE MISURE
 Ci sono studi in cui la fisica si sposa con la sociologia. Studi in cui i nomi prendono, ad esempio, il posto dei numeri. È il caso di una ricerca appena pubblicata sui Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) - la rivista dell’Accademia delle Scienze USA - condotta da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di fisica della Sapienza Università di Roma e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). Si tratta di un’analisi dei nomi scelti per i bambini nati negli Stati Uniti dal 1910 al 2012, sulla base dei dati resi pubblici dall’ufficio statistico americano. “L’indagine ha consentito di stabilire come le correlazioni culturali fra gli Stati americani si siano modificate nel tempo, mostrando un drastico cambiamento nella parte finale del XX secolo”, spiega Enzo Marinari, fisico teorico della Sapienza e dell’INFN, tra gli autori della ricerca.
Ci sono studi in cui la fisica si sposa con la sociologia. Studi in cui i nomi prendono, ad esempio, il posto dei numeri. È il caso di una ricerca appena pubblicata sui Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) - la rivista dell’Accademia delle Scienze USA - condotta da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di fisica della Sapienza Università di Roma e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). Si tratta di un’analisi dei nomi scelti per i bambini nati negli Stati Uniti dal 1910 al 2012, sulla base dei dati resi pubblici dall’ufficio statistico americano. “L’indagine ha consentito di stabilire come le correlazioni culturali fra gli Stati americani si siano modificate nel tempo, mostrando un drastico cambiamento nella parte finale del XX secolo”, spiega Enzo Marinari, fisico teorico della Sapienza e dell’INFN, tra gli autori della ricerca.
L’indagine è basata sull’uso di tecniche di analisi avanzate, matematiche e numeriche. Per un fisico è, infatti, normale analizzare dati sperimentali, per confermare o smentire una teoria, e fare predizioni future di un certo fenomeno. Quello che cambia in questo particolare studio è, però, la natura stessa dei dati sperimentali. “La nostra misura sono i nomi”, sottolinea Marinari. Nomi che raccontano storie. “Studiando la dinamica dei grandi nomi - riflette il fisico italiano - si può, infatti, osservare come mutano i rapporti tra le varie parti di un Paese, nel nostro caso gli Stati Uniti, e quali sono le influenze reciproche”. Dall’analisi dei dati emerge, ad esempio, che fino agli Anni settanta gli Stati del Nord, così come quelli del Sud, tendevano ad agire all’unisono, e fra i due gruppi non c’erano correlazioni degne di rilievo. Invece, nel periodo più recente ci sono stati notevoli cambiamenti, e sono emersi chiari legami fra i comportamenti della East Coast e della West Coast. “Stati anche geograficamente lontani, hanno iniziato a fare scelte simili - afferma Marinari -. Perché questo accada non possiamo, però, dirlo. Il nostro resta, infatti, uno studio da fisici, non da sociologi. Quello che noi facciamo - conclude Marinari - è analizzare ciò che succede, senza tuttavia interpretarlo. Un lavoro, quest’ultimo, che spetta ai sociologi”.
Il Sulcis si converte all’Energia Oscura
 Firmato un protocollo d’intesa tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e la Regione Autonoma della Sardegna per lo sviluppo del progetto Aria, finalizzato alla realizzazione di un’innovativa infrastruttura di ricerca presso la miniera di Monte Sinni, nel bacino carbonifero del Sulcis, in Sardegna Continue reading
Firmato un protocollo d’intesa tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e la Regione Autonoma della Sardegna per lo sviluppo del progetto Aria, finalizzato alla realizzazione di un’innovativa infrastruttura di ricerca presso la miniera di Monte Sinni, nel bacino carbonifero del Sulcis, in Sardegna Continue reading
UNA SETTIMANA DI COLLISIONI PER LHCf
 A LHC, il superacceleratore del CERN di Ginevra, si è da poco concluso un periodo di attività (run) speciale, dedicato all’esperimento LHCf. Nella settimana di presa dati, con collisioni protone-protone all’energia record di 13 TeV e bassissima luminosità, sono stati raccolti circa 40 milioni di eventi. L’esperimento LHCf, installato a 140 metri dal punto in cui i protoni interagiscono all’interno del rivelatore ATLAS, è dedicato allo studio delle particelle neutre che vengono prodotte a piccolissimo angolo nelle collisioni, studio che è importante per la calibrazione dei modelli di interazione tra particelle, gli adroni (come i protoni di LHC), utilizzati per la fisica dei raggi cosmici di altissima energia.
A LHC, il superacceleratore del CERN di Ginevra, si è da poco concluso un periodo di attività (run) speciale, dedicato all’esperimento LHCf. Nella settimana di presa dati, con collisioni protone-protone all’energia record di 13 TeV e bassissima luminosità, sono stati raccolti circa 40 milioni di eventi. L’esperimento LHCf, installato a 140 metri dal punto in cui i protoni interagiscono all’interno del rivelatore ATLAS, è dedicato allo studio delle particelle neutre che vengono prodotte a piccolissimo angolo nelle collisioni, studio che è importante per la calibrazione dei modelli di interazione tra particelle, gli adroni (come i protoni di LHC), utilizzati per la fisica dei raggi cosmici di altissima energia.
“Grazie anche alla collaborazione e all’impegno del team responsabile dell’acceleratore, la presa dati è andata benissimo, decisamente soddisfacente”, commenta Alessia Tricomi, responsabile per l’INFN di LHCf. L’analisi online degli eventi ha permesso di vedere i fotoni, i pioni neutri e i mesoni eta più energetici finora mai osservati in un acceleratore. In particolare, i pioni neutri sono stati ricostruiti nell’analisi online già con una precisione migliore del 5%, senza applicare alcuna correzione. “È un risultato davvero promettente - sottolinea Tricomi – e nei prossimi mesi gli scienziati della collaborazione LHCf si concentreranno sulla fase di analisi dei dati: in particolare, grazie alla presa dati comune con ATLAS, gli eventi raccolti durante questo speciale run permetteranno una ancor migliore comprensione dei meccanismi di interazione adronica, e questo ci aiuterà a comprendere un po’ di più i raggi cosmici che incessantemente “piovono” dallo spazio sul nostro pianeta”, conclude Tricomi.
ARIA: DALLE MINIERE DEL SULCIS UNA RISORSA PER LA CACCIA ALLA MATERIA OSCURA
 COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO INFN - REGIONE SARDEGNA. Siglato un accordo tra INFN e Regione Sardegna per la riconversione della miniera di Monte Sinni.
COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO INFN - REGIONE SARDEGNA. Siglato un accordo tra INFN e Regione Sardegna per la riconversione della miniera di Monte Sinni.
L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e la Regione Autonoma della Sardegna hanno firmato un protocollo d’intesa per il prossimo sviluppo del progetto Aria, finalizzato alla realizzazione di un’innovativa infrastruttura di ricerca presso la miniera di Monte Sinni, nel bacino carbonifero del Sulcis, in Sardegna. L’accordo consentirà di aprire un tavolo di discussione tra INFN e Regione Autonoma della Sardegna per l’installazione nella miniera di un impianto tecnologico di altissimo livello, in corrispondenza dei pozzi di Seruci. L’altezza e il diametro dei pozzi, la loro configurazione, con accessi multipli e sistemi di sicurezza integrati e, soprattutto, la disponibilità di un’autostrada camionabile dalla superficie fino alla profondità di 500 metri, sono condizioni ideali per l’installazione in sicurezza di un impianto che avrà dimensioni uniche al mondo.
L’obiettivo del progetto Aria è la separazione dell’aria nei suoi componenti fondamentali, elementi che trovano utilità in diversi ambiti di ricerca e applicazione. Uno di questi componenti, l’argon-40, è un materiale pregiatissimo che permetterà lo sviluppo di una innovativa tecnica per la ricerca della materia oscura ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) dell’INFN, progettata e realizzata dall’esperimento DarkSide, una collaborazione internazionale guidata dall’INFN, che vede la partecipazione di oltre trenta istituti provenienti da nove nazioni (Italia, Brasile, Cina, Francia, Polonia, Russia, Spagna, Svizzera, USA).
Inoltre, altri componenti dell’aria, come l’ossigeno-18 e il carbonio-13, sono elementi che, propriamente e completamente selezionati e isolati, sono anch’essi pregiatissimi in diversi ambiti di applicazione. Questi elementi hanno un mercato internazionale di grande rilievo, dal quale tuttavia il nostro Paese è attualmente escluso. Grazie alle infrastrutture uniche della miniera di Monte Sinni, il progetto Aria permetterebbe di sviluppare un ciclo produttivo in grado di abbassare notevolmente i costi energetici di produzione di questi materiali speciali, rendendoli più accessibili e fruibili. In questo modo, Aria contribuirebbe ad aumentare la disponibilità di tecnologie avanzate per lo screening medico, incluse le tecniche diagnostiche per la lotta al cancro. Utilizzando per la separazione dell’aria strutture pre-esistenti, l’innovativo processo tecnologico comporterà inoltre un impatto ambientale nullo.
Il primo passo di Aria prevede l’installazione di una torre-pilota di distillazione criogenica: un prototipo di dimensioni tali da rappresentare un unicum al mondo. Questo progetto, senza precedenti a livello internazionale, è reso possibile dalla cooperazione tra INFN, con ruolo di guida e coordinamento dei gruppi di ricerca coinvolti, e Princeton University, oltre che dal contributo cruciale di aziende italiane. La prima fase di progettazione è già partita, grazie a un finanziamento garantito dalla US National Science Foundation (US-NSF).
“Il progetto Aria è un esempio importante di come la ricerca di base può offrire l’opportunità di un potenziale sfruttamento industriale delle tecniche sviluppate per gli esperimenti alla frontiera della conoscenza”, è il commento di Fernando Ferroni, presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, “L’INFN è da sempre attento alla ricaduta nel contesto produttivo delle sue iniziative di ricerca. In questo caso specifico, l’Istituto presta grande attenzione a questo progetto e al suo modello di collaborazione: ci adopereremo con energia per il suo successo”.
“È un progetto sul quale lavoriamo da mesi d’intesa con l’INFN, convinti che ricerca e collaborazione con le eccellenze internazionali, tra cui anche la Princeton University, siano una delle opportunità per rinnovare il ruolo della Sardegna e delle sue attività economiche”, commenta Francesco Pigliaru, Presidente della Regione Autonoma della Sardegna. “Lavoreremo perché alla ricerca di base, in presenza di buoni risultati, segua la “scalabilità” industriale del progetto, in considerazione delle ottime prospettive di mercato e dello sviluppo tecnologico legato all’utilizzo di tali prodotti. La Sardegna, oltre che per le precise esigenze infrastrutturali legate alla realizzazione del progetto, si è proposta come partner affidabile grazie alla scelta precisa di puntare su ricerca e innovazione, all’alto livello di qualificazione dei lavoratori che potranno essere coinvolti e alla disponibilità di eccellenze provenienti dalle Università sarde. L’iniziativa – conclude il Presidente Pigliaru – è un ottimo esempio di come anche settori critici quali quello in cui opera la Carbosulcis possono trovare nuovi indirizzi e potenzialità grazie alle competenze maturate, alle tecnologie sviluppate e all’apporto di nuova ricerca”.
“Siamo chiaramente eccitati per l’impatto positivo sulle ricerche di materia oscura in corso ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Ma la sfida è altrettanto eccitante dal punto di vista del possibile piano di sviluppo industriale e di trasferimento tecnologico”, è il commento di Cristian Galbiati, della Sezione INFN di Milano, professore all’Università di Princeton e coordinatore del progetto DarkSide. “Se giochiamo bene le carte a nostra disposizione, potremmo stabilire un nuovo ciclo produttivo ad altissimo contenuto tecnico, con potenziali ricadute sull’occupazione locale. Abbiamo trovato in Carbosulcis un partner eccezionale”, aggiunge Galbiati, “Le competenze tecnologiche dei suoi ingegneri e tecnici sono di elevatissimo livello: sarebbe stato impossibile arrivare alla dimostrazione di fattibilità di questo progetto senza il loro contributo determinante.”
“Il progetto Aria è di notevole importanza strategica regionale e nazionale e di elevato interesse per le possibili ricadute a livello locale che le attività condotte potrebbero comportare”, commenta Speranza Falciano, membro della Giunta Esecutiva dell’INFN che segue i progetti di trasferimento tecnologico, “Lo spin-off di questa tecnologia potrebbe permettere un impatto importante a livello sociale, delle imprese sul territorio e dei centri di ricerca della Regione Sardegna, a partire dall’Università, - prosegue Falciano – e settori che ne tratterrebbero beneficio vanno dalla medicina diagnostica, con particolare riferimento allo screening avanzato di diverse patologie, all’energia pulita, dall’eco-sostenibilità, all’agricoltura, e allo studio del cambiamento del clima.”
NOTE
L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN
L’INFN è l’Ente Pubblico di Ricerca dedicato allo studio dei costituenti fondamentali della materia e delle leggi che li governano. Svolge attività di ricerca, teorica e sperimentale, nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. Ha, tra i suoi compiti istituzionali, il trasferimento tecnologico al fine della promozione dell’economia e dell’occupazione sul territorio nazionale.
La ricerca della materia oscura ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
I rivelatori oggi in funzione ai laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN per la ricerca diretta della materia oscura hanno come obiettivo quello di rivelare gli urti delle particelle di materia oscura sui nuclei del materiale-bersaglio. Per aumentare la sensibilità del rivelatore è necessario che il materiale utilizzato sia particolarmente puro, privo cioè di radioattività, perché l’eventuale segnale di materia oscura non sia coperto dal rumore di fondo. In questo contesto, tra gli isotopi di interesse per le ricerche dell’INFN, ricopre particolare rilievo l’argon-40, utilizzato per lo studio della materia oscura in grandi rivelatori dove l’argon è raffreddato e liquefatto, così come avviene nell’esperimento DarkSide, installato da una collaborazione internazionale presso i Laboratori del Gran Sasso dell’INFN.
CONTATTI
Francesca Scianitti, INFN - Ufficio Comunicazione
francesca.scianitti@presid.infn.it
06 6868162 - 347 4600445
Giulia Clarkson, Regione Autonoma della Sardegna - Ufficio Stampa
giuclarkson@gmail.com
328 6283125
UNO SCUDO MAGNETICO SUPERCONDUTTIVO PER ASTRONAUTI
 Oggi, 17 giugno, si svolge a Parigi il workshop “Superconducting Magnet Technology for Space” ospitato dal CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) nell’ambito del progetto EU-FP7 Space Radiation Superconducting Shield (SR2S) coordinato dall’INFN.
Oggi, 17 giugno, si svolge a Parigi il workshop “Superconducting Magnet Technology for Space” ospitato dal CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) nell’ambito del progetto EU-FP7 Space Radiation Superconducting Shield (SR2S) coordinato dall’INFN.
Il progetto SR2S, iniziato nel 2013 e che si concluderà nel dicembre 2015, studia come sviluppare tecnologie per proteggere gli astronauti dalle radiazioni provenienti dal sole e dai raggi cosmici, nel corso di missioni di esplorazione planetaria nello spazio profondo. Il progetto studia le tecnologie necessarie per lo sviluppo di un sistema di schermatura attiva basata su magneti superconduttori, un vero e proprio "scudo magnetico" che sfrutta la superconduttività per eliminare il consumo di energia e ridurre al minimo il peso della struttura magnetica.
Sono state studiate varie configurazioni tra cui l’innovativa configurazione a “pumpkin” (zucca) che consente di ottenere uno schermatura efficace riducendo al massimo il materiale attraversato dalle particelle incidenti, evitando così la generazione di particelle secondarie.
SR2S è coordinato dal prof. Roberto Battiston dell’ASI e, oltre all’ INFN (Genova, Perugia, Bologna, Milano, Roma, Trento), vede la partecipazione di due importanti imprese del settore spaziale, Thales Alenia Space e OHB-CGS, insieme a CERN, CEA e Columbus Superconducting.
Il sito web del progetto http://www.sr2s.eu
Continue readingMATERIA OSCURA: POSSIBILI TRACCE NELLA RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA EXTRAGALATTICA
 A dispetto del suo nome, la materia oscura potrebbe non essere poi così oscura. Potrebbe, infatti, essere associata alla radiazione elettromagnetica: questa è l’ipotesi di un team di scienziati delle sezioni INFN di Torino, Roma Tre e Trieste, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e della Chinese Academy of Science. In particolare, lo studio, pubblicato oggi su Physical Review Letters (PRL), descrive una correlazione fra l’emissione gamma extragalattica catturata dal telescopio spaziale Fermi, cui INFN e INAF collaborano, e la distribuzione di materia oscura cosmica ricostruita dal catalogo di galassie 2MASS. Secondo gli autori dello studio, potrebbe trattarsi di un'impronta indiretta della presenza della sfuggente materia che permea un quarto dell’universo. Questa associazione nella radiazione gamma potrebbe quindi individuare la prima possibile traccia non gravitazionale della materia oscura: finora, infatti, tutte le nostre ipotesi si sono basate su osservazioni relative ai suoi effetti gravitazionali.
A dispetto del suo nome, la materia oscura potrebbe non essere poi così oscura. Potrebbe, infatti, essere associata alla radiazione elettromagnetica: questa è l’ipotesi di un team di scienziati delle sezioni INFN di Torino, Roma Tre e Trieste, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e della Chinese Academy of Science. In particolare, lo studio, pubblicato oggi su Physical Review Letters (PRL), descrive una correlazione fra l’emissione gamma extragalattica catturata dal telescopio spaziale Fermi, cui INFN e INAF collaborano, e la distribuzione di materia oscura cosmica ricostruita dal catalogo di galassie 2MASS. Secondo gli autori dello studio, potrebbe trattarsi di un'impronta indiretta della presenza della sfuggente materia che permea un quarto dell’universo. Questa associazione nella radiazione gamma potrebbe quindi individuare la prima possibile traccia non gravitazionale della materia oscura: finora, infatti, tutte le nostre ipotesi si sono basate su osservazioni relative ai suoi effetti gravitazionali.
Lo studio appena pubblicato su PRL mostra, infatti, che il segnale è compatibile con l’ipotesi che la materia oscura possa essere costituita dalle cosiddette Weakly Interacting Massive Particle (WIMP), per le quali lo studio identifica un intervallo di valori di massa compreso fra 10 e 300 GeV. “Le WIMP, come suggerisce il loro stesso nome, possiedono un'interazione, anche se debole, - spiega Nicolao Fornengo, della sezione INFN di Torino, tra gli autori dello studio -. Quindi, dovrebbero andare incontro a un possibile processo mutua annichilazione o di decadimento”. “Quello che abbiamo fatto nel nostro studio - sottolinea il fisico italiano - è cercare, al di fuori del gruppo di galassie di cui fa parte la nostra Via Lattea, il cosiddetto Gruppo Locale, un segnale gamma associabile a questi processi. Per fare questo, abbiamo correlato la mappa della radiazione gamma misurata dal satellite Fermi con la distribuzione di galassie del catalogo 2MASS, che rappresenta un tracciatore della distribuzione di materia oscura nell'Universo. E in questo modo abbiamo trovato un segnale e mostrato che è compatibile con le WIMP. Si tratta di una prima analisi di questo tipo di correlazioni - precisa Fornengo -, che mostra come questa tecnica sia molto promettente”.
L’esistenza della materia oscura è stata più volte dedotta dalla misura indiretta dei suoi effetti gravitazionali sulla materia ordinaria. Finora, però, la sua natura è rimasta ben nascosta, riuscendo a sfuggire a qualsiasi tentativo di osservazione. Gli studiosi sanno che esiste, ma non com’è fatta. La sua natura fondamentale resta, infatti, uno dei principali interrogativi della fisica moderna. Al CERN di Ginevra, ad esempio, gli scienziati stanno provando a imbrigliarla con il nuovo corso del superacceleratore LHC (Large Hadron Collider), il cosiddetto RUN2. Grazie all’energia record di 13 TeV, infatti, i fisici sperano di produrre quelle particelle che si presume compongano la materia oscura. Allo stesso tempo, gli astrofisici scrutano il cosmo a caccia di tracce di materia oscura fossile che possa rendersi visibile, ad esempio, ai sofisticati occhi dei telescopi spaziali. Come il satellite Fermi, che la sta cercando tra le pieghe della radiazione gamma.
“Le strutture cosmologiche sono dominate dalla presenza di materia oscura, - spiega Nicolao Fornengo -. Le nostre conoscenze sul fatto che questa elusiva materia esiste sono tutte di natura gravitazionale. Se, però, emettesse anche radiazione, dovremmo avere una correlazione tra la radiazione gamma misurata da Fermi e la distribuzione della materia oscura nell’Universo. La correlazione che abbiamo individuato possiede le giuste caratteristiche che ci si attende se prodotta dalla materia oscura - chiarisce il fisico INFN -. Non possiamo, tuttavia, escludere al momento che sia dovuta a un’altra fonte, come ad esempio l'emissione gamma prodotta dai nuclei galattici attivi. Occorreranno nuovi studi per chiarirlo. Nei prossimi mesi, ad esempio, - aggiunge Fornengo - Fermi rilascerà nuovi dati. Sono, inoltre, in preparazione nuovi cataloghi di galassie Tutto questo permettera' di affinare la tecnica che stiamo utlizzando. In prospettiva, con l'arrivo dei dati che misurano il cosiddetto effetto di lente gravitazionale debole (weak lensing gravitazionale), si potanno ottenere mappe dettagliate della distribuzione di materia oscura nell'Universo. Fra qualche anno saranno infatti disponibili i dati del Dark Energy Survey, e successivamente del satellite Euclid dell'ESA. Questi nuovi potenti strumenti d'indagine - conclude Fornengo - ci permetteranno di migliorare di molto le misure di correlazione che stiamo sviluppando e potenzialmente di fornire una risposta chiara all'origine del segnale che abbiamo studiato oggi”.
BUON COMPLEANNO A GIANPAOLO BELLINI
 È un evento che riunisce ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN fra i maggiori esperti di fisica delle particelle e del neutrino quello organizzato il 16 giugno per festeggiare gli ottant’anni Gianpaolo Bellini. Parteciperanno alla giornata Fernando Ferroni, Stefano Ragazzi, Ettore Fiorini, Oleg Zaimidoroga, Daniele Pedrini, Giulio Manuzio, Franz von Feilitzsch, Gerd Heusser, Alessandro Bettini, Alexander Derbin, Daniel Vignaud, colleghi e amici di Bellini che ripercorreranno l’intera carriera scientifica dello scienziato.
È un evento che riunisce ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN fra i maggiori esperti di fisica delle particelle e del neutrino quello organizzato il 16 giugno per festeggiare gli ottant’anni Gianpaolo Bellini. Parteciperanno alla giornata Fernando Ferroni, Stefano Ragazzi, Ettore Fiorini, Oleg Zaimidoroga, Daniele Pedrini, Giulio Manuzio, Franz von Feilitzsch, Gerd Heusser, Alessandro Bettini, Alexander Derbin, Daniel Vignaud, colleghi e amici di Bellini che ripercorreranno l’intera carriera scientifica dello scienziato.
Fisico dell’INFN e professore dell’Università degli Studi di Milano, Gianpaolo Bellini con la sua attività di ricerca ha dato contributi originali in quattro aree della fisica delle particelle elementari: risonanze delle particelle (Particle Resonances), collisioni di particelle ad alta energia su nuclei complessi (High-Energy Particle Collisions on complex Nuclei), sapori pesanti (Heavy Flavours) e fisica del neutrino. Bellini è stato per moltissimi anni portavoce della collaborazione Borexino, l’esperimento per lo studio dei neutrini che, da quando è in funzione ai Laboratori sotterranei del Gran Sasso, ha portato a importanti risultati sullo studio di queste elusive particelle, dalle quali ci aspettiamo un contributo determinante alla conoscenza del nostro universo. Nel corso della sua lunga attività Bellini è stato ricercatore sperimentale in fisica delle particelle elementari, responsabile di un vasto gruppo di ricerca presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Milano e dell’INFN. Ha svolto ricerche sperimentali all’acceleratore Serpukhov nel centro IHEP in URSS. E` stato poi visiting scientist presso il CERN a Ginevra e il Fermilab di Chicago, dove ha condotto vari esperimenti.
Dal 1973 al 1994 è stato membro del Consiglio Direttivo dell’INFN, dal 1983 al 1989 membro della Giunta Esecutiva e nel 1988-1989 vicepresidente dell’Istituto. È stato inoltre membro del Consiglio della Società Europea di Fisica e dell’ECFA (European Committee for Future Accelerators), direttore del programma INFN Superconduttività Applicata per la R&S e la costruzione di prototipi di cavità superconduttive per LEP2, dei dipoli di LHC, di B0 (prototipo di Atlante Barrel Toroid), e per lo sviluppo di tecniche innovative per cavità superconduttive. Nel 2005 è stato membro del gruppo di esperti di fisica del comitato nazionale per la valutazione della ricerca scientifica in Italia, ed ha ricoperto inoltre il ruolo di direttore della Scuola di Dottorato in Fisica, Astrofisica e Fisica Applicata dell’Università Statale di Milano, e di coordinatore della rete europea ISAPP (scuola europea di dottorato in fisica astroparticellare). Gianpaolo Bellini è autore di circa 230 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e negli atti di conferenze internazionali. Ha inoltre curato 10 volumi sulla fisica delle particelle elementari e cinque volumi di fisica per l’università.
SCOPERTA L’APPARIZIONE DEL NEUTRINO TAU
COMUNICATO STAMPA 
L’esperimento internazionale OPERA (Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus) ai Laboratori del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) ha rivelato la quinta interazione di neutrino tau. Il neutrino ha iniziato il suo “volo” al CERN come neutrino muonico e, dopo aver attraversato 730 km sottoterra, ha raggiunto i Laboratori del Gran Sasso, manifestandosi come neutrino tau. Questo importante risultato è stato appena annunciato nel corso di un seminario tenutosi ai Laboratori del Gran Sasso. “La rivelazione del quinto neutrino tau è estremamente importante: l’osservazione diretta della transizione da neutrini muonici a tau ha ora raggiunto per la prima volta la precisione statistica di 5 sigma, il livello richiesto per una scoperta nella fisica delle particelle elementari”, sottolinea Giovanni De Lellis, dell’INFN e dell’Università Federico II di Napoli, a capo del team internazionale di OPERA. “Possiamo dunque definitivamente annunciare la scoperta dell’apparizione di neutrini tau in un fascio di neutrini muonici”. La rivelazione di neutrini tau dall’oscillazione di neutrini muonici fu la motivazione per la quale l’esperimento OPERA fu progettato alla fine degli Anni novanta. “Questo compito è estremamente difficile a causa di due contrapposte richieste: un rivelatore enorme, molto pesante e una accuratezza micrometrica. La sfida è raggiungere la scala delle migliaia di tonnellate con un rivelatore basato sulla tecnologia delle emulsioni nucleari, una tecnica fotografica unica nell’assicurare l’accuratezza richiesta”, spiega lo scienziato di OPERA.
L’esperimento internazionale OPERA coinvolge 140 fisici da 26 Istituti di ricerca in 11 Paesi. Inizialmente introdotte come una possibile ipotesi, le oscillazioni sono state per diversi decenni un fenomeno poco conosciuto. Nel 1998 fu mostrato che i neutrini muonici prodotti nelle interazioni di raggi cosmici giungono sulla Terra meno numerosi di quanto atteso. Il risultato riportato ieri conferma definitivamente che i neutrini mancanti sono proprio quelli muonici che hanno oscillato in neutrini tau. “Il risultato ottenuto è stato possibile grazie all’impegno costante di tutti i ricercatori coinvolti nel progetto, all’eccellente prestazione del fascio di neutrini del CERN e al sostegno degli enti finanziatori”, conclude De Lellis.
L’esperimento CNGS (CERN Neutrinos to Gran Sasso)
I neutrini prodotti al CERN di Ginevra hanno viaggiato verso il laboratorio sotterraneo del Gran Sasso in Italia. Grazie alla probabilità estremamente piccola di interagire con la materia, dopo aver viaggiato 730 km attraverso la Terra, i neutrini hanno raggiunto il rivelatore OPERA, un gigante di circa 4000 tonnellate, di 2000 m3 di volume e nove milioni di film fotografici: qui una piccola frazione dei neutrini che sopraggiungono hanno interagito con il rivelatore, producendo delle particelle che poi vengono osservate. In natura esistono tre tipi, detti “sapori”, di neutrini: elettronico, muonico e tau. OPERA ha cercato neutrini tau sapendo che tutti quelli che hanno lasciato il CERN erano neutrini muonici, visto che il fascio di neutrini era stato prodotto appositamente di questo tipo. Se si rivelano neutrini di un sapore diverso, si ha, quindi, la prova delle oscillazioni avvenute durante il loro volo di 730 km. Dopo aver rivelato i primi neutrini muonici prodotti al CERN nel 2006, l’esperimento ha preso dati per cinque anni, dal 2008 alla fine del 2012. Il primo neutrino tau è stato pubblicato nel 2010. Il secondo e il terzo sono stati riportati rispettivamente nel 2012 e nel 2013. Il quarto è stato pubblicato nel 2014. In perfetto accordo con le previsioni teoriche.
Gli scienziati continueranno l’analisi dei dati raccolti, alla ricerca di altri neutrini tau prodotti dall’oscillazione di neutrini muonici e cercheranno di misurare i parametri dell’oscillazione, usando per la prima volta i neutrini tau prodotti dall’oscillazione. Gli sviluppi tecnologici effettuati per l’esperimento OPERA saranno utilmente impiegati in altri esperimenti, non solo nel campo dei neutrini.
Continue reading